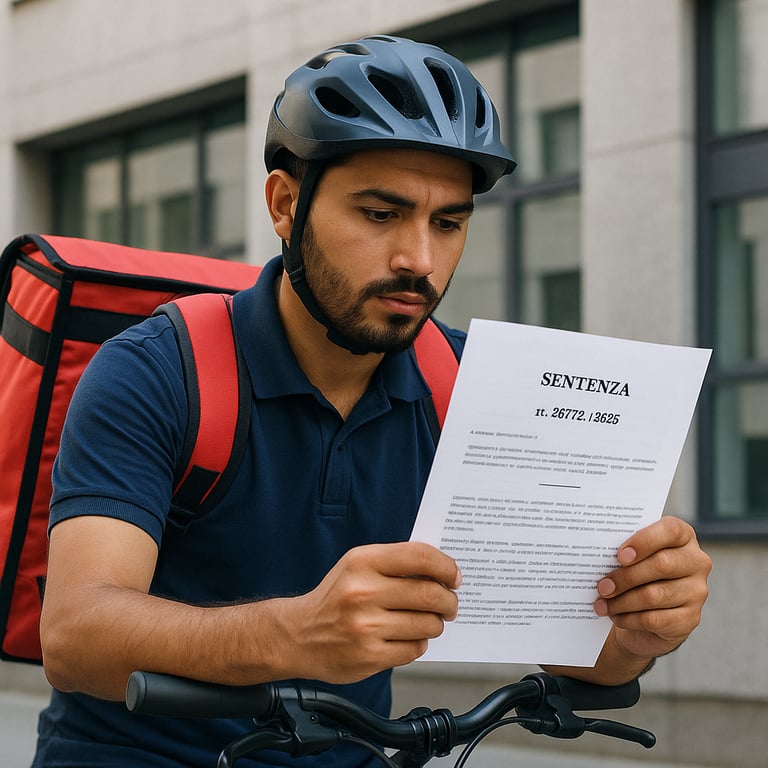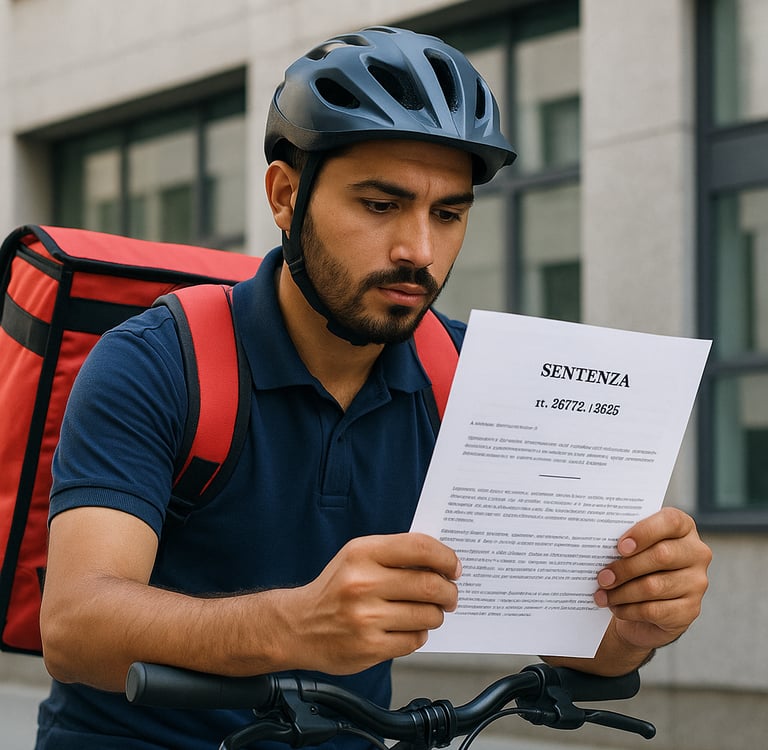Lavoro
Rider e lavoro etero-organizzato: la Cassazione consolida il modello “ibrido” dell’art. 2 D.Lgs. 81/2015
Dott. Alessandro Cervellino
11/4/2025

1. La sentenza 28772/2025
Con la sentenza n. 28772 del 31 ottobre 2025, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – è tornata a pronunciarsi sullo status giuridico dei ciclofattorini operanti tramite piattaforme digitali, confermando un orientamento ormai consolidato: anche i rider formalmente qualificati come lavoratori autonomi devono essere considerati collaboratori etero-organizzati, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 81/2015, con conseguente applicazione della disciplina sostanziale del lavoro subordinato.
La decisione, che ha rigettato il ricorso proposto da una società di delivery contro la sentenza della Corte d’appello di Torino, ribadisce la funzione “rimediale” della norma introdotta dal Jobs Act: garantire tutele analoghe a quelle dei dipendenti per quei lavoratori che, pur operando formalmente come autonomi, svolgono la propria attività all’interno di un’organizzazione imposta dal committente.
2. Il quadro normativo: l’art. 2 D.Lgs. 81/2015 e la funzione rimediale
L’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 81/2015 stabilisce che le tutele del lavoro subordinato si estendono alle collaborazioni che presentano tre caratteristiche fondamentali:
carattere continuativo della prestazione,
natura personale (originariamente “esclusiva”, poi modificata in “prevalentemente personale” dal D.L. 101/2019),
modalità di esecuzione organizzate dal committente, anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro.
La norma non crea un tertium genus, ma un meccanismo correttivo che interviene in presenza di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in cui il collaboratore si trovi, di fatto, in una posizione di subordinazione economico-funzionale. Tale impostazione, già delineata da Cass. n. 1663/2020 (caso Foodora), è ora pienamente confermata dalla pronuncia del 2025, che ne rafforza il valore sistematico.
3. L’analisi della Cassazione: i tre requisiti della etero-organizzazione
La sentenza 28772/2025 rappresenta un passaggio di consolidamento giurisprudenziale, nel quale la Corte esamina puntualmente i tre requisiti richiesti dall’art. 2 D.Lgs. 81/2015.
3.1. La personalità della prestazione
Il primo motivo di ricorso della società riguardava la presunta assenza del requisito di personalità, in ragione dell’utilizzo di mezzi propri (biciclette o scooter) da parte dei rider. La Suprema Corte ha definito irrilevante tale circostanza: la proprietà dei mezzi, infatti, attiene alla qualificazione giuridica del rapporto (autonomo o subordinato), non alla disciplina applicabile. L’essenza della prestazione resta personale fintanto che il lavoratore non possa delegarla a terzi, come accertato in concreto.
La Corte ribadisce così la “dissociazione” tra qualificazione formale e disciplina sostanziale, cardine dell’art. 2, che consente di applicare le tutele del lavoro subordinato anche in assenza di una formale subordinazione contrattuale.
3.2. La continuità
Sul secondo motivo, la Cassazione respinge l’argomento datoriale secondo cui la collaborazione dei rider, svolta in modo intermittente e priva di obbligo di disponibilità, non potrebbe qualificarsi come continuativa.
La Corte chiarisce che la continuità non coincide con la costanza giornaliera della prestazione, ma con la stabilità funzionale del rapporto: nel caso di specie, la reiterazione delle attività di consegna nel tempo e la presenza di contratti a durata plurimensile sono elementi idonei a soddisfare il requisito.
Viene richiamato l’orientamento già espresso in relazione alle collaborazioni ex art. 409 n. 3 c.p.c., evidenziando che la continuità deve essere valutata in senso giuridico e non meramente quantitativo.
3.3. L’etero-organizzazione
Il terzo profilo, centrale nel giudizio, riguarda l’etero-organizzazione. La Corte conferma che il sistema di gestione delle consegne, basato su un algoritmo che stabilisce unilateralmente tempi, luoghi e modalità della prestazione, integra pienamente il requisito previsto dall’art. 2.
La Cassazione richiama la propria giurisprudenza (Cass. n. 1663/2020) per ribadire che il riferimento ai “tempi e luoghi di lavoro” è esemplificativo, non tassativo. L’etero-organizzazione può emergere anche quando il committente determina unilateralmente le modalità operative, indipendentemente da un controllo diretto o fisico.
Nel caso concreto, la piattaforma decideva autonomamente quale rider assegnare a una determinata consegna, sulla base di parametri informatici (prossimità, tempi, disponibilità), e imponeva l’esecuzione entro 30 minuti, con possibilità di penalità: elementi sufficienti a configurare un potere organizzativo tipicamente datoriale.
4. La dissociazione tra qualificazione e disciplina applicabile
Uno degli aspetti più innovativi della pronuncia è l’esplicita riaffermazione della “dissociazione concettuale” tra la qualificazione giuridica del rapporto e la disciplina applicabile.
L’art. 2 D.Lgs. 81/2015 non trasforma il rapporto di collaborazione in un contratto di lavoro subordinato, ma estende le tutele del lavoro dipendente a determinate collaborazioni che ne condividono la sostanza economico-organizzativa.
In tale prospettiva, il lavoratore resta autonomo sotto il profilo formale, ma è protetto da regole tipiche della subordinazione (retribuzione, ferie, malattia, sicurezza, previdenza), con un’applicazione rimediale della normativa a tutela del soggetto più debole.
Si tratta di un principio che ridefinisce il perimetro del diritto del lavoro nell’economia digitale, introducendo una tutela graduata e funzionale all’effettiva dipendenza organizzativa, anziché alla forma contrattuale prescelta.
5. Implicazioni operative per le imprese e la contrattazione collettiva
Le conseguenze della sentenza 28772/2025 sono rilevanti per le piattaforme digitali e, più in generale, per tutti i committenti che impiegano collaboratori autonomi in contesti organizzativi fortemente centralizzati.
5.1. Effetti sulla gestione dei rapporti di collaborazione
Le imprese dovranno valutare con attenzione il grado di autonomia effettiva riconosciuto ai collaboratori, poiché un controllo algoritmico o una pianificazione unilaterale delle attività può comportare l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato.
L’utilizzo di piattaforme digitali che definiscono in modo automatico turni, orari e percorsi può costituire elemento decisivo per l’inquadramento ex art. 2.
È necessario garantire trasparenza e tracciabilità dei criteri algoritmici, anche ai fini della compliance con le disposizioni del D.Lgs. 104/2022 (cd. “decreto trasparenza”).
5.2. Ruolo della contrattazione collettiva
La Cassazione richiama, indirettamente, l’importanza del riferimento ai CCNL di settore per la determinazione del trattamento economico dei collaboratori etero-organizzati.
Nel caso esaminato, i giudici di merito avevano applicato il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, riconoscendo ai rider l’inquadramento al VI livello.
La giurisprudenza spinge così verso una contrattualizzazione collettiva dei rapporti di piattaforma, quale strumento di bilanciamento tra flessibilità operativa e tutela dei lavoratori.
6. Considerazioni conclusive
La sentenza n. 28772/2025 segna un ulteriore passo nella definizione del perimetro giuridico del lavoro etero-organizzato. La Corte di Cassazione consolida l’idea che il diritto del lavoro non si fonda più esclusivamente sul vincolo di subordinazione formale, ma sulla dipendenza funzionale del prestatore dall’organizzazione altrui.
Il principio di fondo è quello della prevalenza della realtà sostanziale sulla forma contrattuale: il diritto si adegua alle nuove modalità di organizzazione del lavoro digitale, senza rinunciare al proprio nucleo protettivo.
Per i professionisti del lavoro, la pronuncia offre due indicazioni essenziali:
la necessità di analizzare le dinamiche operative effettive dei rapporti di collaborazione, al di là della loro veste formale;
l’opportunità di prevenire contenziosi attraverso modelli contrattuali trasparenti, procedure di selezione non discriminatorie e sistemi di gestione algoritmica che non comprimano la libertà organizzativa dei collaboratori.
La Cassazione riafferma un principio di equilibrio: il lavoro dei rider resta autonomo nella forma, ma subordinato nella sostanza alle regole dell’organizzazione digitale, e dunque meritevole della stessa tutela garantita ai lavoratori dipendenti.