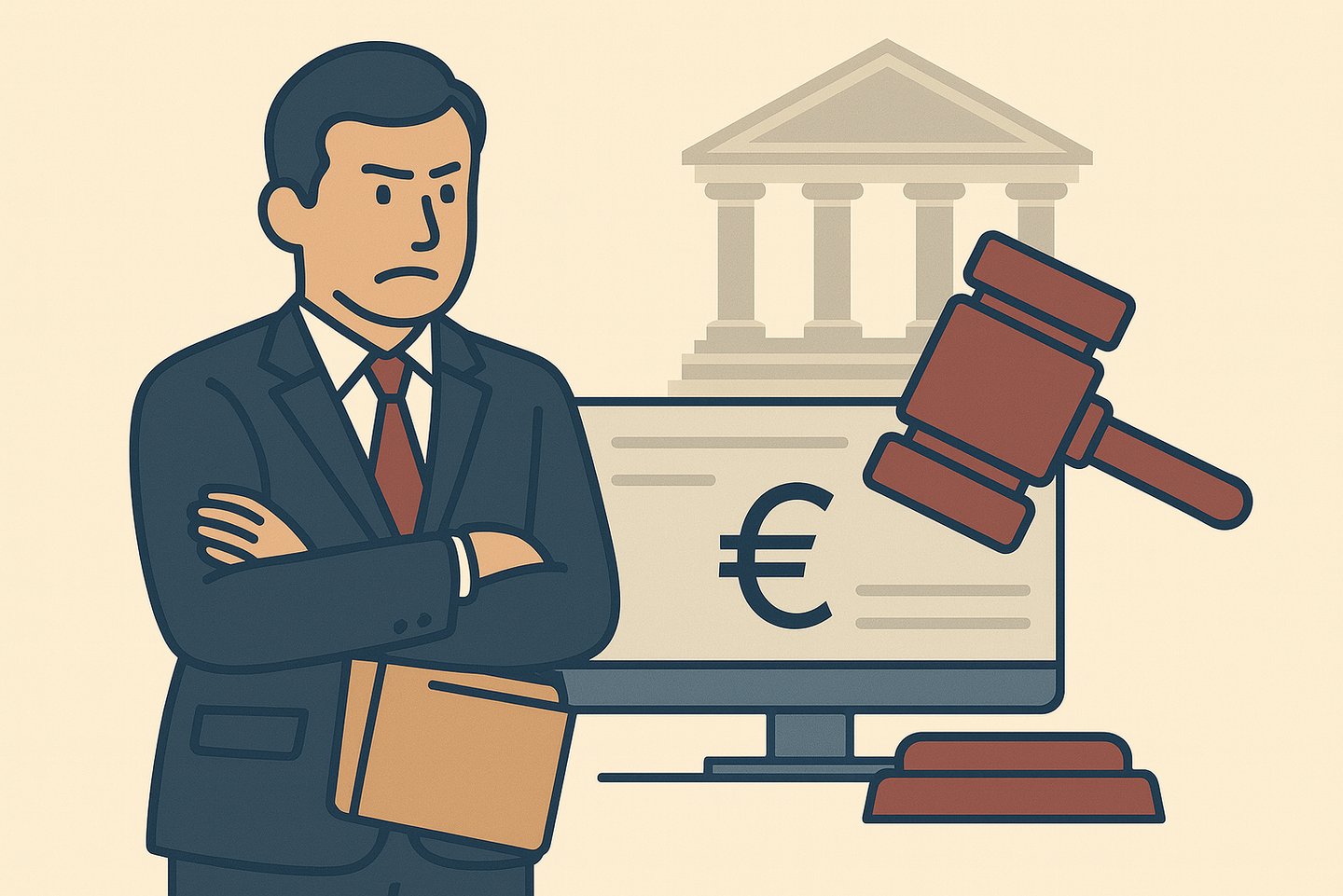Diritto Societario
Responsabilità gestoria e imputazione causale nella crisi d’impresa: profili sostanziali e processuali nella giurisprudenza di merito
Avv. Francesco Cervellino
8/29/2025
L’ordinanza del Tribunale di Milano, Sezione feriale, del 21 agosto 2025, offre un contributo rilevante alla sistematizzazione dei presupposti giuridici dell’azione risarcitoria esperibile dai creditori sociali nei confronti degli amministratori di società a responsabilità limitata (S.r.l.), ai sensi dell’articolo 2476, comma 6, del codice civile. Il provvedimento, intervenendo sulla revoca di un sequestro conservativo precedentemente concesso, pone l’accento sull’esigenza di una rigorosa verifica del nesso eziologico tra condotta gestoria e pregiudizio patrimoniale, sancendo in via giurisprudenziale la centralità dell’onere probatorio quale presidio dell’effettività della responsabilità.
È principio ormai consolidato che l’amministratore di S.r.l., pur non rispondendo personalmente dei debiti sociali in ragione dell’autonomia patrimoniale perfetta dell’ente, possa essere chiamato a rispondere ex delicto o ex contractu qualora la sua condotta, connotata da violazione degli obblighi di legge o statutari, abbia prodotto un danno diretto alla società ovvero ai creditori sociali. In tale contesto, l’articolo 2476, comma 6, c.c. configura un’azione speciale di natura aquiliana, fondata su un titolo di responsabilità extracontrattuale, a tutela dei creditori danneggiati da atti gestori in violazione del generale dovere di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.
L’ordinanza in commento si segnala per la chiarezza con cui ribadisce che la crisi d’impresa, pur potendo costituire l’esito di una gestione negligente o colpevole, non è di per sé idonea a fondare la responsabilità degli amministratori, ove non sia dimostrata la riconducibilità eziologica della stessa a condotte qualificabili come mala gestio. La decisione milanese si pone in perfetta continuità con l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’azione dei creditori non può fondarsi su presunzioni semplici, bensì necessita dell’allegazione e della prova di fatti concreti, atti gestori specifici e dannosi, secondo un impianto probatorio articolato e coerente (Cass., 24 febbraio 2014, n. 4377).
Nella fattispecie, il giudice di merito ha chiarito che l’inattività degli amministratori, consistita nella mancata costituzione in giudizio o nell’omesso pagamento di alcuni debiti, non può essere ritenuta ex se sufficiente a integrare gli estremi della responsabilità risarcitoria, qualora si collochi in una fase già caratterizzata da dissesto economico e non risulti connotata da condotte antidoverose tipiche. Analogamente, la mera insufficienza patrimoniale, se non sorretta da un impianto contabile documentato e correlato a condotte gestorie specifiche, non legittima l’adozione di misure cautelari conservative. Ne discende l’inidoneità del fumus boni iuris a sostenere la misura interdittiva, che pertanto è stata revocata in sede di riesame.
La decisione recepisce altresì un orientamento consolidato in dottrina e giurisprudenza circa l’inesistenza di una responsabilità oggettiva dell’amministratore, anche qualora investito di una carica formale o di fatto. Secondo Cass., 3 febbraio 2017, n. 2954, la responsabilità non può essere desunta automaticamente dalla posizione apicale, ma deve fondarsi su un accertamento specifico del ruolo attivo nella gestione e della violazione di obblighi di diligenza, prudenza e correttezza. Questo principio è stato ribadito da Cass., 12 gennaio 2021, n. 296, e ulteriormente sviluppato nella pronuncia 1° settembre 2023, n. 25631, che ha statuito che, una volta allegata la violazione, incombe sull’amministratore l’onere di dimostrare la conformità della condotta ai criteri di diligentia quam in suis.
Elemento centrale dell’impianto argomentativo del provvedimento è il richiamo al principio della business judgment rule, inteso quale limite funzionale al sindacato giudiziale sulle scelte imprenditoriali. Tale principio, mutuato dall’esperienza nordamericana e ormai stabilmente accolto nella giurisprudenza civile italiana, tutela la discrezionalità gestoria da interventi ex post non giustificati da violazioni manifeste delle regole di condotta. In base a questo criterio, il giudice può sindacare le scelte dell’amministratore solo laddove risultino manifestamente imprudenti, arbitrarie, irrazionali o poste in essere in violazione degli obblighi di lealtà e diligenza previsti dagli articoli 2392 e 2476 c.c.
Sul piano sistematico, l’ordinanza in commento riafferma l’importanza del corretto bilanciamento tra libertà di impresa e protezione dei terzi, ribadendo che la responsabilità gestoria non può tradursi in un’ipoteca permanente sul patrimonio dell’amministratore, ma deve essere limitata ai casi in cui sia riscontrabile una condotta concretamente antigiuridica, produttiva di danno e causalmente riconducibile all’agente. Ne consegue la necessità, per i creditori, di articolare un impianto probatorio che documenti puntualmente il credito certo, l’insufficienza patrimoniale, l’inadempimento degli obblighi conservativi e il nesso di causalità tra condotta e danno.
In ultima analisi, la pronuncia del Tribunale di Milano si inserisce tra quelle decisioni che, nel delimitare le condizioni dell’azione risarcitoria, contribuiscono a rafforzare la certezza del diritto, prevenendo derive punitive e assicurando al contempo la tutela dell’affidamento legittimo dei creditori sociali. In tale ottica, l’amministratore non è chiamato a rispondere in re ipsa del dissesto, ma solo laddove risulti comprovato che la crisi d’impresa costituisca effetto immediato e diretto di una gestione antidoverosa e causalmente efficiente.